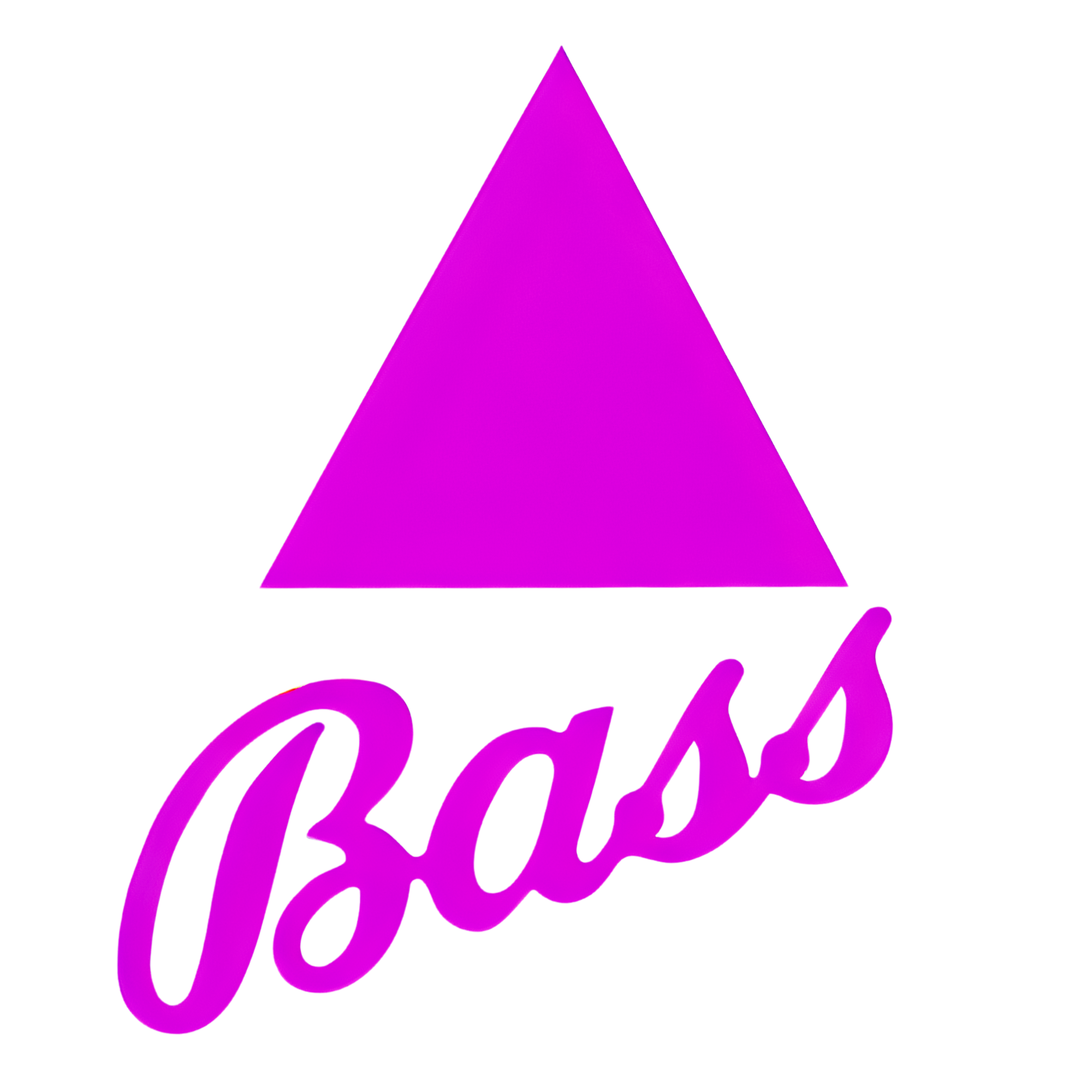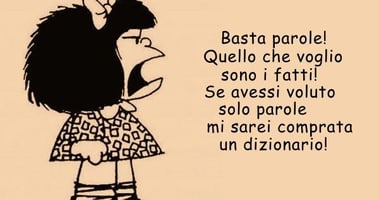Se parlo di guerra, non faccio la guerra. Se parlo di morte, non uccido.
Storia collettiva e storie individuali.
La storia collettiva di un popolo, di una nazione, è complessa per definizione. Le trame e le sottotrame di giochi di potere, economici, tecnologici, militari, tattici, diplomatici, rendono la vita di una nazione estremamente sfaccettata e articolata. Quando, all'Università, nel corso di storia studiavamo il modello dei servizi segreti della Repubblica di Venezia, appariva chiaro già allora come quello che si vede in superficie, nella storiografia "classica", sia solo uno dei tanti modi per rappresentare la storia, quello fatto di date, fatti importanti, regnanti che si scontrano, guerre che si risolvono in poche pagine e le cui motivazioni sembrano legate sempre e solo a conquiste territoriali e problemi dinastici. La realtà, come sappiamo bene, è fatta dell'intreccio di traiettorie di migliaia di persone, dove anche nei regimi più autoritari, per sostenere il potere del singolo monarca o dittatore è necessario un complesso apparato organizzativo e politico che agisce in modo parzialmente indipendente rispetto al rappresentante pubblico. Noi, della storia, conosciamo solo i grandi avvenimenti, quelli che sembrano modificare le sorti macroscopiche dei popoli.
In questo scenario ci sono due elementi di disturbo:
1) Il primo è legato ad un modo diverso di affrontare il tema storiografico puro, ovvero quello più profondo di una storiografia moderna che, da Jaques Le Goff in avanti, ha allontanato lo sguardo dalle fredde cronache militari e dalle date legate ai grandi avvenimenti (1492, la scoperta dell'america, esticazzi...), per comprendere nella descrizione della storia anche le vicende di chi protagonista non è, di chi vive ai margini ma partecipa di una cultura e dello spirito del tempo. A questo, si aggiungono componenti provenienti da altre scienze come l'antropologia o la psicologia sociale o la letterattura di viaggio, che hanno aperto e aprono spiragli su mondi collaterali, questioni non centrali, a fronte delle quali la necessità di approfondimento appare irrinunciabile.
2) Il secondo è legato al fatto che, nella maggior parte dei casi, non sappiamo cosa farcene della storiografia da scuola media. Non ci dice niente, non ci insegna molto. Se all'università è possibile entrare in contatto con un modo diverso di fare storia (e torniamo al punto precedente) è anche vero che per la maggior parte delle persone quel tipo di percorso è semplicemente fuori dai radar. Ma, ed è questo il vero tema di questo secondo punto, alle persone invece piacciono le storie di altre persone. Cioè, la complessità socio politica vista dall'alto, con uno sguardo scientifico, è buona per gli scienziati. Ma la storia del singolo, che sia l'eroe famoso o che sia un underdog (il termine ormai è sdoganato), è una storia che possiamo comprendere, con cui possiamo empatizzare, che ci riesce di facile (o più facile) comprensione. Il successo clamoroso di una trilogia come quella di M di Scurati, tra i mille esempi che si potrebbero citare, appartiene a questo tipo di fattore: non chiedeteci di leggere noiosi trattati storico politico militari sul fascismo e sulla seconda guerra mondiale. Sono una palla mostruosa e non ci capiamo niente. Non chiedeteci nemmeno di leggere davvero i saggi pop come quello di Paolo Mieli "Fiamme dal Passato". Che si compra, e poi si mette in libreria. Ma se possiamo leggere la storia di un uomo che oggettivamente ha fatto storia, vista dal di dentro, con l'intreccio personale che sovrasta quello storico politico e ci si lega, ma da una prospettiva che rimane umana, singola, personale, allora sì, quello lo leggiamo volentieri. E non è una critica, anzi, questo tipo di testi sono estremamente interessanti (se poi sono accurati nelle ricostruzioni come M, meglio ancora).
La nostra mente riesce a cogliere le storie delle persone. Non ci importa che milioni di soldati siano morti in centinaia di guerre. Ma che quel soldato lì, quel Paolo, quel Mike, quel Francois, ci svelino la loro storia dentro la storia, allora sì che c'importa. Perché possiamo capire le storie personali anche senza essere storici. Possiamo apprendere dallo sviluppo di un singolo essere umano, o di un piccolo gruppo di donne e uomini, quello che c'è da apprendere. Non riusciamo a farlo se invece della lettura umana, empatica, indivudale, si passa ad una lettura scientifica, statistica, numerica. Del resto, c'è una celebre frase, attribuita (probabilmente con errore) a Stalin, che dice così: “Una singola morte è una tragedia, un milione di morti sono una statistica.” La tragedia è un genere letterario. La statistica è un genere scientifico di cui riusciamo a comprendere solo qualche numero sul giornale, senza mai afferrarne le cause sottostanti.
Lo specchio delle storie individuali, quindi, accende la passione molto più delle spiegazioni razionali, scientifiche, statistiche.
Una storia può cambiare la Storia, la storiografia quasi sempre resta lettera morta.